Può la lettura ritenersi una forma di meditazione?
Osho, il famoso mistico indiano, in “Iniziazione alla meditazione” fa una precisa distinzione tra concentrazione, contemplazione e meditazione. La concentrazione sarebbe la focalizzazione della propria mente su un unico punto; è uno stato mentale. La mente non si agita più, non è più sballottata tra mille pensieri ma resta ferma su un oggetto e questo le permette di scendere in profondità. La contemplazione, invece, è una concentrazione allargata, il suo campo d’azione è più ampio. Non è focalizzata su di un unico punto ma tuttavia è confinata ad un unico argomento. La mente in questo caso si muove ma solo entro in confini di un solo campo d’indagine. La meditazione, per Osho, non è né una né l’altra ma si trova esattamente a metà strada tra le due; dice il maestro: “Quando contempli un particolare oggetto, affiorano cose che richiedono un’attenzione maggiore, per cui mediti”.
La meditazione non si può fare, non la si può praticare: non è un’attività ma la cessazione di ogni attività. Quando non si fa nulla, quando si esiste semplicemente e si è nel proprio centro, completamente rilassati, quella è meditazione. La si può solo comprendere.
Esiste poi però anche la “meditazione di consapevolezza“. Quando si è calmi e rilassati, quando si è pienamente coscienti del proprio corpo, della propria mente e di quello che accade all’esterno, allora si può cominciare ad agire: piccole azioni, rimendo sempre centrati su se stessi.
Secondo queste definizioni la lettura NON dovrebbe essere meditazione, proprio perché la lettura sarebbe concentrazione, un’attività della mente, focalizzata su un unico punto, la pagina che ho davanti.
Però.
Per conoscenza personale e diretta di entrambe – sono una lettrice appassionata da quando ho imparato a leggere e ho frequentato il mio primo corso di meditazione durante l’Università – so che ci sono degli elementi che le accomunano. Innanzitutto entrambe avvengono in uno stato alterato di coscienza: si esce dalla coscienza “ordinaria” e si entra in un’altra dimensione, dove si perde contatto con la realtà che ci circonda, ci si dimentica di sé, dei propri problemi, del proprio corpo persino – Ti è mai successo di dimenticarti che ore sono quando leggi? O che ti trovavi su un treno? O chiudere le pagine accorgendoti solo in quel momento di avere una gamba informicolata o la schiena dolorante per aver letto tutta storta per ore? A me, sempre.
In questo caso, secondo me, la lettura può essere considerata una meditazione di consapevolezza: mi trovo in uno stato di grande calma, sono consapevole di me, del mio corpo e di quanto mi circonda e scelgo di “abbandonare” il mondo ordinario per immergermi, grazie alla mia immaginazione e con la guida dell’autore del testo, in un mondo nuovo, per me straordinario, dove potrò fare nuove sperienze, esattamente come se le vivessi in prima persona – grazie ai miei neuroni-specchio – ma mediate, non dirette. Faccio esperienza ma senza rischiare di farmi davvero male o di soffrire come se le vivessi in prima persona. In questo senso la lettura di romanzi angoscianti – penso ai gialli, ai thriller, agli horror o ai miei amatissimi gotici – può aiutare a guardare in faccia le proprie paure e i propri “mostri”, fornendo delle tecniche per affrontarli e ridurli. Una sorta di cura “omeopatica” per la paura.
La “Lettura meditativa” non è perciò una lettura spontanea o superficiale. Si tratta all’opposto di una lettura profonda, alla quale ci si può – e ci si deve – allenare. All’inizio è meglio cominciare in un luogo tranquillo, silenzioso, “protetto” da interferenze esterne. La famosa “stanza tutta per sé”, dove nessuno si permetterà di venire a disturbarci. Dobbiamo sentirci bene, rilassate, in pace. Non dobbiamo avere fretta: possiamo cominciare decidendo quanto tempo dedicare alla lettura e rispettarlo, magari mettendo una sveglia se abbiamo paura di sforare. Concediamoci di leggere lentamente, di fermarci se ne sentiamo l’esigenza; lasciamo fluire le emozioni, ascoltiamoci. Perché la lettura sia davvero efficace dobbiamo avere il tempo di riflettere su quanto letto, di far emergere ricordi, di contemplare i pensieri che ci attraversano in quel momento, senza identificarci con essi ma semplicemente osservandoli. Facciamoci prendere per mano dall’autore, con fiducia, e guardiamo dove ci porta. Non temiamo di andare sempre più in profondità. Leggiamo con piena presenza mentale: questa è lettura di consapevolezza. Portiamo la nostra attenzione sull’attimo presente e su quello che stiamo vivendo, a due livelli differenti: primo, sulla sensazione della carta tra le dita, sul profumo delle pagine, sul silenzio, sul vento tiepido che entra dalla finestra, sul canto degli uccellini appena fuori. Secondo, sulla vita che stiamo vivendo, grazie alla nostra immaginazione, nella pagina. Sono qui, nella mia camera da letto, in una mattina d’inverno e sono lì, nella campagna inglese, in una sera d’estate, sorseggiando un cocktail in attesa che succeda qualcosa.
La lettura non è un’attività passiva. Noi lettori siamo vivi, più vivi che mai quando leggiamo. Io consiglio sempre nei miei laboratori di vivere il testo: sottolineare, scrivere appunti a margine, inserire segnapagina per indicare i quattro pilastri narrativi – che insegno nei miei corsi – , inserire post-it quadrati per le riflessioni più lunghe, scrivere una scheda-libro alla fine. Sono tutti modi per dialogare con il testo e con l’autore e lo scambio che ne risulta è un vero e proprio atto di creazione.
“Il testo è vivo e la lettura è una danza” ( Mircea Eliade)




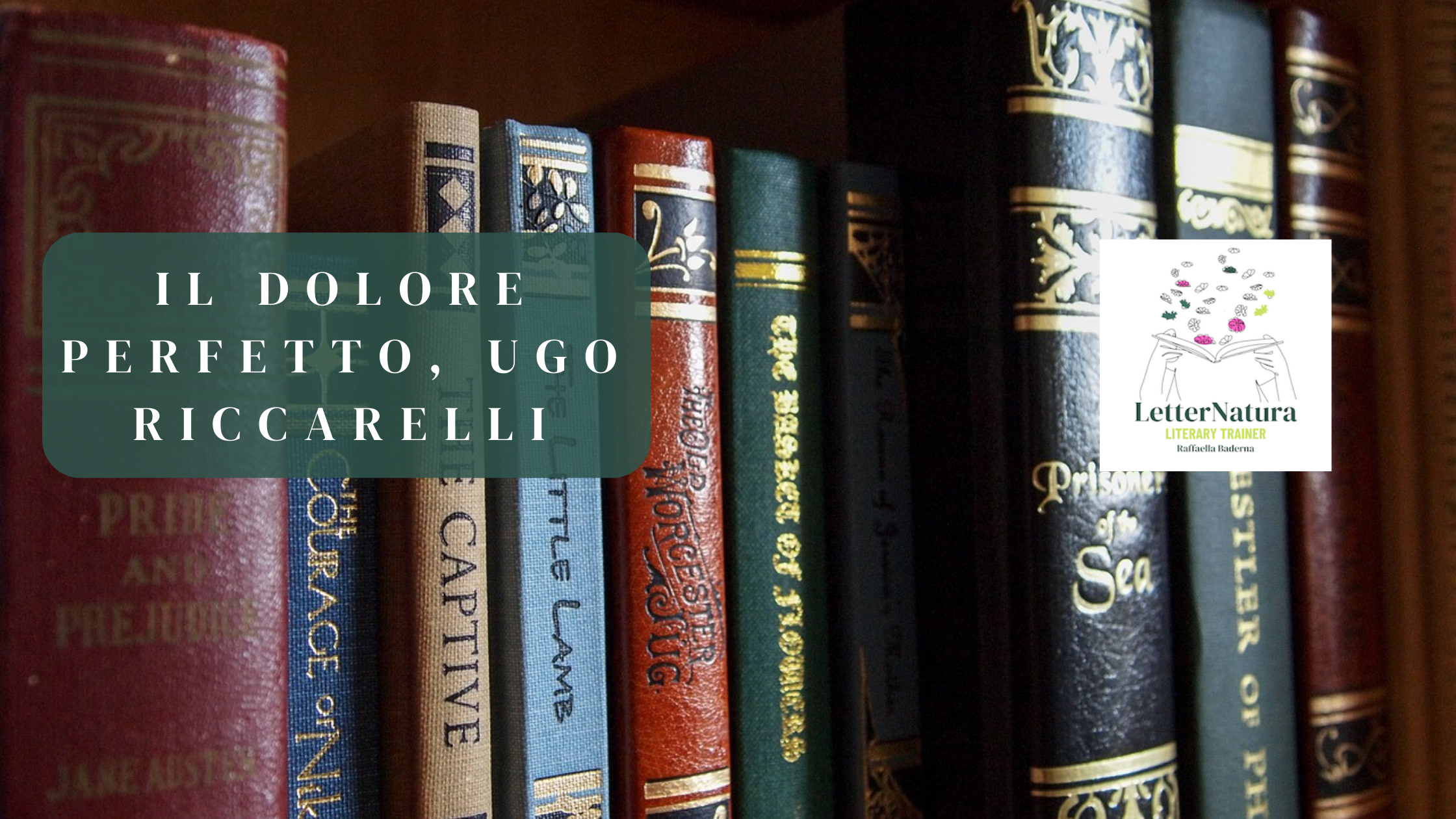


Scrivi un commento