Italo Calvino, nel suo celebre saggio “Perché leggere i classici”, che raccoglie trentacinque scritti sugli autori che avevano avuto per lui importanza, definisce i classici “quei libri di cui si sente dire di solito: «Sto rileggendo…» e mai «Sto leggendo…»”. Voleva evidenziare così la vergogna che coglie i lettori “forti” di fronte alla mancata lettura di un libro famoso. Ma, ci rassicura Calvino, dato il numero enorme di opere fondamentali che ciascuno “dovrebbe” leggere, sarebbe impossibile recuperarle tutte. In realtà, continua, la rilettura costituisce un piacere ancora più grande di una prima lettura: questa avviene in gioventù, dove abbiamo meno strumenti e meno esperienza per poter interpretare quello che leggiamo; nella maturità, invece, l’occhio per il dettaglio si è fatto più acuto, abbiamo molti libri letti alle spalle e possiamo accedere quindi a livelli di significato più profondi, non accontentandoci di quello superficiale. Ci dovrebbe essere, secondo lui, “un tempo nella vita adulta dedicato a rivisitare le letture più importanti della gioventù”, anche perché ogni rilettura porta sempre a nuove scoperte.
Guendalina Middei nel suo ” Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita” ci esorta a chiederci “Quali sono i classici che io vorrei leggere, che ho bisogno di leggere. Quali classici possono farmi tornare ad avere più entusiasmo, più compassione, più ardore, più anima, più cuore. Quali possono (…) salvarmi (…) farmi ritrovare: Me stesso, il mio tempo, il mio cuore.” E ancora: “Ai classici chiesi di guarirmi, di insegnarmi a splendere, di rendere più ardito il mio sguardo e più temerario il mio cuore”.
Ho scelto di partire con la citazione di questi due autori per introdurre un argomento a me molto caro: la lettura/rilettura dei classici. Tutti noi ne abbiamo letti alcuni a scuola e li abbiamo amati od odiati. Purtroppo spesso ne abbiamo letto solo alcuni brani fuori contesto, perdendo così quel rapporto esclusivo e solitario che solo la lettura di un’opera completa, in un perenne botta e risposta con l’autore, può darci. Rileggerli – o meglio ancora – leggerli per la prima volta da adulti, in tranquillità, senza l’assillo di un’interrogazione, può essere una scoperta incredibile. Vorrei prendere il meglio ( secondo me ) dei due autori citati sopra: non leggiamo perché si deve ” ma solo per amore” (Calvino), non leggiamo quello che leggono gli altri o che va di moda ma leggiamo per salvarci:” da relazioni sbagliate, dall’apatia, dalla monotonia di un tempo che non viene vissuto, da genitori mancati e da genitori che mancano” (Middei).
Mi sento molto vicina a queste definizioni perché occupandomi di Libroterapia il mio sguardo è già allenato a passare dai contenuti voluti dall’autore, dal contesto storico-letterario, dalle tecniche di scrittura a quello che quel testo può trasmettere a me, lettrice degli anni venti del Duemila; a passare dalla mente ( che resta comunque il primo fondamentale filtro ) al cuore. Da quello che sarebbe opportuno leggere a quello che ho bisogno io di leggere in questo particolare momento della mia vita.
Nei miei laboratori di Libroterapia umanistica cerco sempre, ove possibile, di inserire un classico; in genere propongo romanzi contemporanei o comunque abbastanza recenti, soprattutto all’inizio del percorso quando ancora non conosco bene le partecipanti, ma poi, con l’avanzare dei mesi, cerco – ad un certo punto – di inserire un testo un po’ più complesso, che necessita un’attenzione e una riflessione più profonda. Non tutti sono abituati a leggere i classici e a prima vista potrebbero spaventare: ci vuole allenamento, e abitudine, e un’apertura mentale maggiore per poter arrivare a godere di una simile esperienza.
Dall’inizio di quest’anno ho deciso di leggere un classico al mese: ho cominciato con Tolstoj a gennaio ( uno breve, “La sonata a Kreutzer”), un gotico inglese a febbraio e un altro romanzo inglese a marzo. Ho la fortuna di poter leggere diversi libri in un mese, fa parte del mio lavoro, ma consiglio a tutti di mettersi – o ri-mettersi – a leggere i classici. Uno al mese. O uno ogni tanto. Per allenare la mente con linguaggi un po’ più complessi; per allenare lo sguardo con situazioni meno consuete e apparentemente lontane da noi. Resterete stupiti da quanto personaggi scritti e immaginati nell’Ottocento siano vicini a noi per pensieri e sensibilità; a quanta affinità ci sia tra il loro sentire e il nostro; a quante cose hanno da insegnarci sulla vita e sui sentimenti loro che hanno vissuto in epoche dove non c’era niente di quello che ci circonda e che utilizziamo noi oggi tutti i giorni. Lasciatevi cullare dalla loro prosa lenta e ricca, lasciatevi prendere per mano con fiducia e andate a Parigi, guardate in su: la vedete la splendida Cattedrale? Andate a Londra, la Londra misteriosa, nera di fumo e carbone; andate a Mosca, scivolando sul ghiaccio in una slitta oppure venite qui vicino a me, in quel posto splendido che tutti potete raggiungere aprendo un libro, “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti”. Io ci vado una volta alla settimana, quando posso, e non smetto mai immaginare quella barca che si allontana colma di rimpianto e nostalgia.
Se vuoi intraprendere questo viaggio meraviglioso alla scoperta dei classici assieme a me, ho creato un nuovo servizio di consulenza letteraria che si chiama AIUOLA. Trascorreremo insieme un’ora online e poi ti fornirò una lista di classici adatti a te e alle tue inclinazioni per cominciare a conoscere questo mondo. Ti insegnerò inoltre a leggere “libroterapicamente” e a compilare una tua scheda-libro. Se poi vorrai, potremo proseguire il viaggio insieme con un percorso di Libroterapia basato sulla tua lista; deciderai tu quanti romanzi desideri esplorare assieme a me e per quanto tempo.
“Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire” e anche “I classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti”. Grazie Calvino.




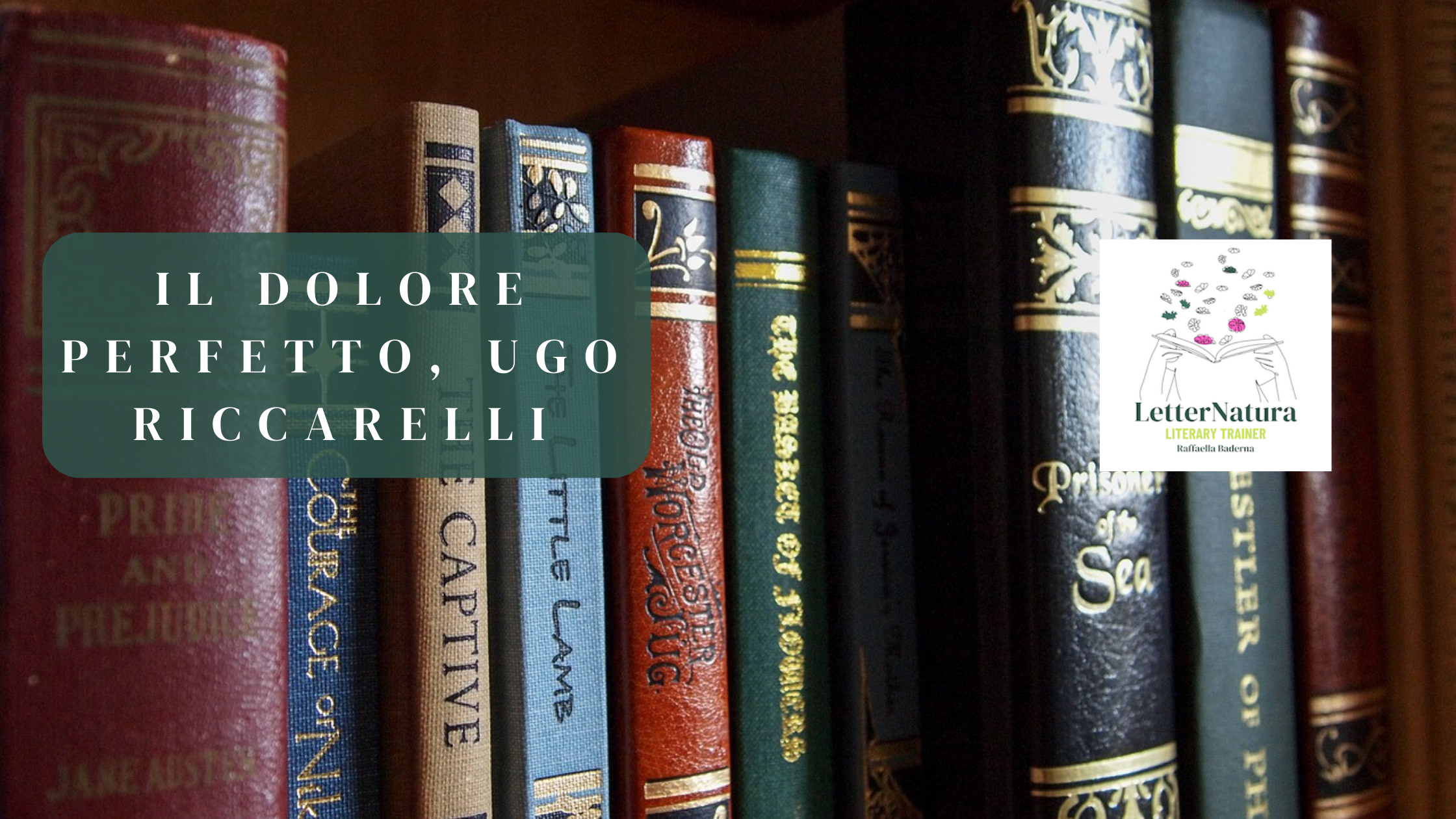

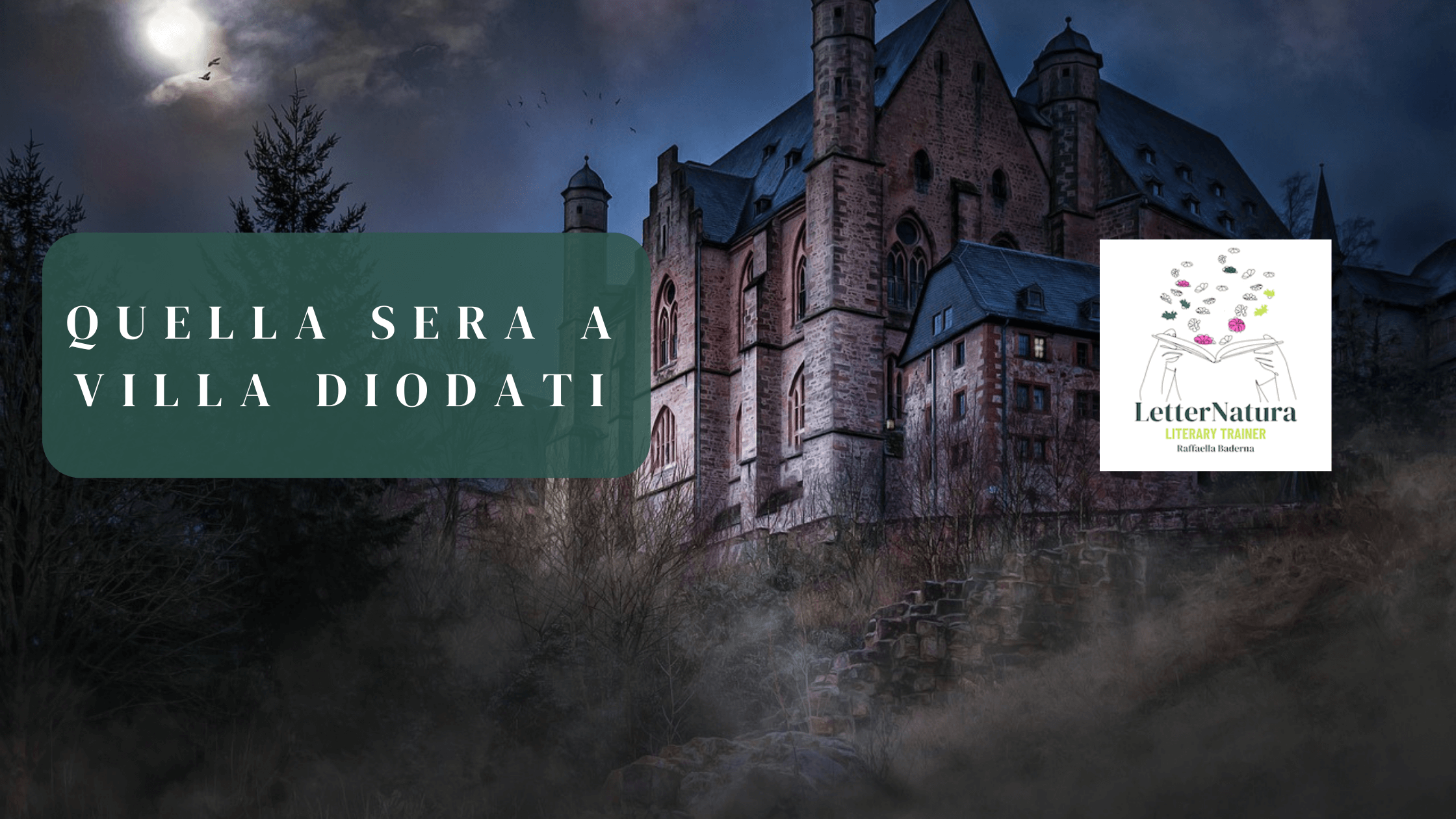
Scrivi un commento